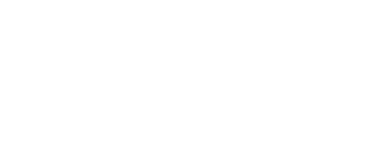19 Feb Quarantena al ritorno dalle vacanze: possibile causa di licenziamento?
Tra l’anno 2020 e l’inizio dell’anno 2021 siamo, nostro malgrado, diventati esperti di termini che un tempo almeno la metà di noi conosceva appena.
Termini come pandemia, mascherina, zona rossa sono diventati, nostro malgrado, all’ordine del giorno.
Un altro termine con il quale siamo purtroppo entrati in contratto è il termine “quarantena”.
Per quanto tale termine rappresentasse in passato un periodo di isolamento forzato che le navi dovevano rispettare prima di attraccare al porto (nel 1448 il Senato veneziano prolungò il periodo d’isolamento da 30 fino a 40 giorni dando origine al termine quarantena, originariamente forma veneta per quarantina), ancora oggi, nonostante i secoli trascorsi, rappresenta un periodo di isolamento al quale soggetti che sono entrati in contatto con il virus o che tornino da zone per la quale la quarantena è prescritta, sono tenuti.
Ovviamente una delle conseguenze del dover trascorrere un periodo in quarantena è l’astensione dalla prestazione lavorativa (salvo smart-working).
Ma il datore di lavoro, nel caso in cui un dipendente si rechi scientemente, per le vacanze, in un luogo al ritorno dal quale dovrà rimanere in quarantena per un determinato periodo di tempo assentandosi dal luogo di lavoro, quali tutele può avere?
Premesso che il diritto alle ferie è un diritto inderogabile, un lavoratore che scelga di andare in ferie in un luogo per il quale, al rientro, è previsto un periodo di isolamento, e decida di tornare proprio a ridosso della ripresa dell’attività lavorativa, può essere validamente licenziato.
Così si è espresso recentemente il tribunale di Trento, rigettando l’impugnazione del licenziamento comminato a una lavoratrice recatasi in Albania per le vacanze estive e successivamente licenziata per assenza ingiustificata, con riferimento al periodo trascorso in quarantena.
Secondo la sentenza infatti la lavoratrice avrebbe violato uno dei principi cardine su cui si basa il diritto del lavoro: la buona fede (ex art. 1375 c.c.).
Con il suo comportamento la lavoratrice avrebbe infatti minato irrimediabilmente il rapporto fiduciario intercorrente tra la stessa e il datore di lavoro (oltre al danno creato all’organizzazione aziendale) ledendo la buona fede che contraddistingue il rapporto di lavoro, così come ogni altro rapporto contrattuale, e del conseguente necessario bilanciamento degli interessi contrapposti tra datore di lavoro e dipendente, che rappresenta proprio un criterio di attuazione della buona fede a cui le parti del rapporto sono reciprocamente tenute.
Infatti, per quanto, come detto, non sia minimamente in discussione il diritto della lavoratrice a godere di un periodo di ferie (peraltro concesso senza problemi dal datore di lavoro), la stessa avrebbe dovuto scegliere un luogo di vacanza o una tempificazione tale da non compromettere l’organizzazione aziendale, a meno che non si dimostri che il luogo scelto per le vacanze costituisca un’esigenza imposta da necessità personali o di salute, imprevedibili e inevitabili, involgenti diritti di rango costituzionale da doversi considerare superiori rispetto a quello aziendale di ottenere la prestazione lavorativa.
Questo caso farà sicuramente discutere ma è certamente un salutare passo in avanti rispetto alla tutela degli interessi datoriali, messi a dura prova dalla pandemia, e che rischiano di vedersi opporre una serie di “capricci” non motivati da necessità ma da interesse.