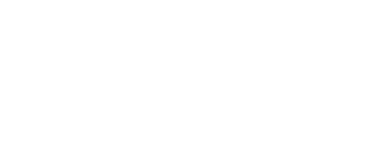26 Feb Danno da demansionamento e onere di prova
L’incessante e rapido mutare delle esigenze organizzative, specie in tempo di pandemia, induce sempre più frequentemente il datore di lavoro ad avvalersi del c.d. ius variandi – disciplinato, nella versione post Jobs Act, dall’art. 2103 Cod. Civ. – per meglio fare fronte alle richieste del mercato.
La flessibilità organizzativa, seppure agevolata dal Legislatore del 2015, rimane tuttavia sottoposta ad una serie di limiti, aventi tra le altre funzioni quella di apprestare tutela alla professionalità del lavoratore dipendente.
Ebbene, sul delicato equilibrio tra esigenze datoriali di elasticità organizzativa e professionalità del lavoratore è di recente tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23144/2020), con particolare riguardo al risarcimento del danno da demansionamento, azionato in giudizio dal lavoratore.
Non basta, a dire del Supremo Collegio, che il lavoratore deduca, quale fonte del danno subito, l’avvenuto demansionamento.
Trattasi, infatti, di un danno (patrimoniale e non) che non può essere ravvisato in re ipsa, vale a dire nella violazione da parte del datore di lavoro dei limiti di “spostamento” prescritti dall’art. 2103 Cod. Civ.
Spetta, dunque, al lavoratore allegare in sede di ricorso la condotta demansionante ascrivibile al datore di lavoro, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta datoriale incriminata e danno di cui si pretende ristoro.